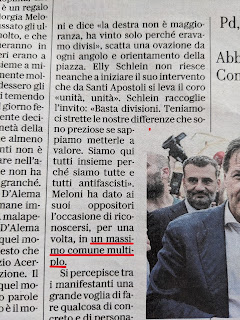Il 28 novembre del 2021 ho scritto un articolo sulla pseudomedicina in Germania.
Ovviamente comunque il problema non riguarda solo la Germania (anche se ivi è particolarmente forte) e non riguarda solo la medicina (anche se in medicina è particolarmente pericoloso).
Oggi vorrei qui parlare di un problema strettamente legato a quanto trattato nell'articolo citato sopra.
Come si è arrivati al punto che (non solo in Italia, ma in Italia in maniera estrema) scienza e pseudoscienza vengano considerate come differenti opinioni di pari dignità e che quindi ogni fuffa abbia dignità di discussione, costringendo esperti, scienziati o comunque persone preparate a doversi confrontare in pubblico con persone che non hanno la minima idea degli argomenti di cui parlano (o sono direttamente in malafede)?
Proviamo a formulare un'ipotesi (anzi: provo a formulare un'ipotesi, una mia ipotesi).
In Italia purtroppo sappiamo che la scienza e la tecnologia sono vilipese e spesso disprezzate. E comunque al meglio considerate non importanti a livello culturale.
Di questo, come già detto e scritto più volte, sono responsabili Giovanni Gentile e soprattutto Benedetto (mai nome fu più sbagliato) Croce.
Verrebbe quindi spontaneo pensare che la situazione di cui sopra possa essere a loro legata.
E invece no.
Stavolta Gentile e Croce non c'entrano.
Di loro possiamo (e dobbiamo) dire tutto il male possibile, ma il loro sminuire l'importanza di scienza e tecnologia non è mai sfociato nella difesa - o almeno sdoganamento - di pseudoscienze e fuffa varia.
Anzi, loro non le consideravano proprio, perché la loro formazione logica (anche se logica in senso filosofico e non matematico-scientifico) li portava a rifiutarle a priori.
Almeno in questo caso loro sono innocenti.
E allora?
Da dove viene questa situazione (oltretutto non limitata solo all'Italia)?
Intanto stabiliamo uno spartiacque: questi discorsi valgono solo per tempi relativamente recenti, essendo la scienza come la intendiamo oggi una costruzione nata tra '600 e '700.
Distinguere tra scienza e pseudoscienza per ciò che ci fu prima di allora è al massimo speculazione accademica, gioco linguistico. In concreto: non ha senso.
Nel nostro discorso ci aiuterà un ottimo libro di Silvano Fuso (libro che ha comunque altri obiettivi rispetto a quello di questo articolo, ma rimane un'ottima guida): Scienza, pseudoscienza e fake news, pubblicato da edizioni Dedalo, prima edizione 1999, ristampa in mio possesso nella collana Senzatempo della stessa edizioni Dedalo, 2021.
In particolare il terzo e l'ottavo capitolo di detto libro.
Tutto parte, paradossalmente, dal successo del metodo scientifico che, partendo dall'illuminismo, portò al positivismo.
Cioè al tentativo di spiegare tutto in termini non tanto scientifici, quanto deterministici.
Infatti il positivismo è una deformazione del metodo scientifico.
Il secondo, detto in maniera terra terra, pone delle regole per cercare delle risposte. Non pretende di arrivare alle risposte (né tantomeno pretende che ci sia sempre una risposta precisa e univoca), pretende "solo" di spiegare come bisogna lavorare per avere la possibilità di arrivarci, quale metodo e quali strumenti logici vadano usati.
Il primo invece, sempre detto in maniera terra terra, dice che se abbiamo i dati di partenza e conosciamo il metodo scientifico... automaticamente arriviamo alle risposte. E queste sono univoche e precise.
E questo è ciò che ha fatto danni.
Perché, ovviamente e prevedibilmente, ha provocato la classica (per dirla in termini fisici) reazione uguale e contraria, soprattutto ove la scienza non era in grado di dare risposte precise (qualsiasi fosse il motivo).
Tutti sappiamo che la scienza in realtà non è deterministica. Per lo meno lo sappiamo da quando conosciamo la fisica quantistica (ma i veri scienziati in realtà lo hanno sempre saputo).
A partire da date condizioni di partenza, l'evoluzione di un sistema dipende non solo da queste ma - almeno - anche dalle condizioni al contorno.
Esempio banale. Voglio vedere come si evolve una reazione chimica. Condizioni di partenza fissate e identiche, ma una volta la provo nel chiuso asettico di un laboratorio e una volta all'aperto, senza particolari precauzioni.
È ovvio che nella maggioranza dei casi vedrò evoluzioni simili, ma comunque diverse.
Per un positivista - semplificando - invece, essendo le condizioni di partenza uguali avrei dovuto ottenere la stessa evoluzione indipendentemente dalle condizioni al contorno.
E qui casca l'asino.
Perché non essendo possibile ottenere sempre le stesse identiche risposte (la natura è solo in parte deterministica, e anche quella parte non nel modo in cui lo si intende comunemente) c'è stata una reazione al positivismo (cosa giustificata) che si è estesa poi a tutta la scienza (cosa non giustificata).
Poi il neopositivismo, sviluppatosi nel 20° secolo (dopo che il positivismo era per molti decenni caduto nel dimenticatoio), considerando la scienza come ideale di oggettività ed elevandola a paradigma del sapere riportò a galla le reazioni antiscientifiche di cui sopra (mai completamente sedate, anche se a lungo ridotte).
Ciò portò la scienza a una situazione di isolamento (la famosa torre d'avorio, anche se se spesso sono gli altri a mettere gli scienziati dentro la stessa, non loro a costruirla per sé stessi) evidenziandone i limiti, come espresse con chiarezza Ludwig Wittgenstein nel suo Tractatus logico-philosophicus:
Noi sentiamo che se pure tutte le possibili domande della scienza ricevessero una risposta, i problemi della nostra vita non sarebbero nemmeno sfiorati. Certo, non rimane allora alcuna domanda; e questa è appunto la risposta.
Insomma, il problema è che la scienza (inconsciamente) ha promesso troppo e chi non ottiene le risposte che chiede se ne allontana, cadendo nelle pseudoscienze, che una risposta la danno sempre, anche se sbagliata.
Ed è questa la forza delle pseudoscienze: non essendo legate a nessun metodo, a nessuna coerenza... hanno sempre un risposta. E quando falliscono hanno sempre una spiegazione.
La scienza invece no.
Alla fine è una questione di comunicazione: la scienza deve imparare a presentarsi per quello che è, a dire quello che può effettivamente fare. Non sperare che il profano lo capisca da solo vedendo i risultati che la scienza porta.
Se no rischia di apparire come stregoneria, come scrisse Gramsci nei suoi Quaderni dal carcere (Q11, §39):
In realtà, poiché si aspetta troppo dalla scienza, la si concepisce come una superiore stregoneria, e perciò non si riesce a valutare realisticamente ciò che di concreto la scienza offre.
Saluti,
Mauro.