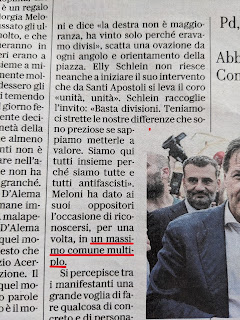Tutti avrete sentito il casino riguardo alle parole di Savona nel suo primo discorso come presidente di Consob.
Prima di tutto, prima di venire ai punti che voglio trattare, per coloro che non hanno già sentito o letto il discorso, vi rinvio al
testo completo, così potete ragionare su di esso con la vostra testa. E valutare obiettivamente i commenti che sentite in giro.
Partiamo dalle levate di scudi sulla "caverna di Socrate".
Siamo sicuri che coloro che si sono scandalizzati per aver sentito Socrate invece che Platone conoscano la filosofia?
Vero che il mito è noto come il mito della caverna di Platone, ma nel testo in cui Platone ne parla (il libro settimo de
La Repubblica) il mito è narrato da Socrate. Platone mette il mito in bocca a Socrate.
E dato che Socrate è stato il maestro di Platone e che tutto ciò che sappiamo di lui è quanto riporta Platone (Socrate non ha lasciato nulla di scritto) è molto probabile che Platone il mito della caverna lo abbia veramente ascoltato da Socrate.
Se volete accertarvene leggetevi
La Repubblica (quella di Platone, non quella di Scalfari). Il libro settimo comincia a pagina 86 della versione nel link.
Per concludere: Platone o Socrate... in questo caso vanno benissimo entrambi.
E veniamo ai contenuti economici, finaziari del discorso, cioè quelli al momento importanti.
Io ne esaminerò uno solo (che è prima matematica e solo dopo economia). Per un'analisi globale del discorso vi rimando a Michele Boldrin e alla sua banda che in
questo video hanno fatto una disanima irriverente ma scientificamente accurata di quanto detto da Savona.
Torniamo a noi.
Il punto di cui vorrei parlare è il famoso debito al 200% del PIL che non sarebbe un dramma (lo trovate a pagina 10 del testo che vi ho messo in link all'inizio).
A parte il fatto che invece sarebbe eccome un dramma, il problema è quando - nel paragrafo successivo - Savona (o chi gli ha scritto il discorso) sostiene che l'importante è che il PIL cresca più del debito.
Il che in astratto può anche essere giusto... se non fosse che la crescita del PIL superiore alla crescita del debito impedirebbe all'Italia di arrivare al 200%.
Facciamo due conti.
Il debito italiano attualmente è al 132,1% del PIL.
Il che significa che posto il PIL a 100, il debito è 132,1.
Facciamo crescere il PIL - per esempio - di 3. Crescere più del debito significa che quest'ultimo al massimo cresce di 2,9 (mi limito sempre solo al primo decimale per semplicità). Abbiamo quindi il PIL a 103 e il debito a 135. Il che significa un rapporto debito/PIL di 135/103=131,1%.
Quindi il rapporto debito/PIL è sceso, anche se il debito assoluto è aumentato.
Continuando a far crescere il PIL più del debito in valori assoluti, il rapporto continuerà a scendere. Non potrà mai raggiungere il 200%.
Va detto che il testo di Savona è un po' ambiguo, lascia la porta socchiusa all'ipotesi che intendesse "facciamo finta di avere un debito al 200%"... ma (a parte il fatto che il buon senso leggendo il tutto esclude questa interpretazione) parlando di temi così importanti per l'economia del Paese è criminale rimanere ambigui. Soprattutto se ricopri una posizione delicata e importante come quella di presidente della Consob.
Saluti,
Mauro.